Hardcore
Scritto in risposta a un recente articolo di Pietro Valle, dedicato al proliferare di edifici “scatolari” nell’architettura contemporanea, questo bel testo di Luca Silenzi riassume in maniera chiara (quasi manualistica) gli elementi principali di una teoria sull’evoluzione delle forme architettoniche che l’autore marchigiano, ormai da un po’ di anni, sviluppa parallelamente al suo lavoro di progettista. Strettamente legato a un’interessante linea di ricerca sul funzionamento del nostro apparato cognitivo, inaugurata nella seconda metà degli anni Settanta da Il Gene Egoista di Richard Dawkins e successivamente approfondita in La Macchina dei Memi di Susan Blackmore, questo scritto parte dall’esplicitazione di alcuni meccanismi fondamentali – seppur normalmente glissati – della progettazione architettonica (“siamo quello che mangiamo”, “progettiamo ciò che riusciamo a rappresentare”, “costruiamo ciò che sappiamo progettare”), per giungere a dimostrare come il moltiplicarsi delle forme sommarie e astratte di cui parla Valle (qui “pure hardcore forms”) non è altro che il prodotto naturale di un periodo storico – quello in cui viviamo – in cui la comunicazione architettonica avviene istantaneamente e su scala globale, e in cui le tecniche di rappresentazione e costruzione hanno raggiunto livelli di sofisticatezza fino a poco tempo fa inimmaginabili. Scrive a tal proposito Luca che “le forme pure, oggi tecnologicamente realizzabili, si rivelano perfettamente adatte ai media con cui oggi vengono divulgate al mondo”: un’acuta osservazione in grado di spiegare non solo l’attuale successo mediatico di architetti “ultraminimalisti” come i portoghesi Aires Mateus, ma anche il grottesco proliferare di edifici falsamente iconici come l’appena completato “grattacielo-ciambella” dello studio milanese AM Project, la cui apparente astrazione geometrica è in realtà un trucco scenografico destinato a nascondere, dietro una facciata perfettamente circolare, la ben poco perfetta forma dell’edificio vero e proprio. Insomma, già che oggi si possono costruire forme astratte con maggior semplicità rispetto al passato, cerchiamo almeno di progettarle bene…
Davide Tommaso Ferrando
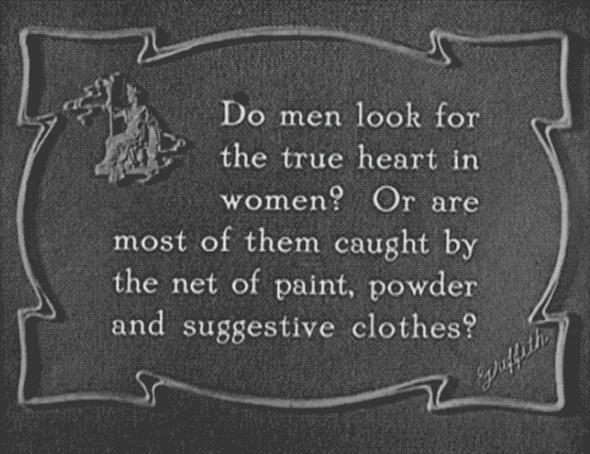
È stato pubblicato qualche settimana fa su Zeroundicipiù un bel testo di Pietro Valle, che si occupa di un aspetto dell’architettura contemporanea a me piuttosto caro, e cioè la diffusione sempre più pervasiva di forme cubiche, scatolari, astratte.
A corredo del testo una serie di edifici presi ad esempio di una supposta deriva astrazionista e comunicativa dell’architettura, che si limita ad essere “elegante, sexy, seducente” tradendo in qualche modo la conquista dello spazio e la rottura dell’involucro perseguiti – con pesanti connotazioni etiche, ma direi anche con grande spargimento di sangue negli spin-off degeneri dell’International Style – dal Movimento Moderno.
Il testo è per molti versi intrigante, ed affronta questioni condivisibili. Anche se mi sembra un poco riduttivo bollare gli splendidi Aires Mateus o i raffinatissimi H&deM come “scatolisti” (ma credo che Valle ne sia perfettamente consapevole): molte delle loro opere dimostrano dal vivo una complessità ed una ricchezza dello spazio – esterno ed interno – che persino gli scatti più fighi e ruffiani non riusciranno mai ad imbrigliare.
E poi, in fin dei conti, non credo che la ‘deriva comunicativa’ dell’architettura sia un problema dei giorni nostri, se di problema si tratta. Non ha tentato già in altri secoli, certa architettura, di essere elegante, sexy [1] o seducente? Solo per evocare qualche link mentale: e il Barocco? E il Neoclassico? E la Sezession?
Io avrei una mia personale teoria su questo argomento, che recentemente ho esposto – anche in Cinese, spero nel buon lavoro del traduttore… – nel prologo ad un pamphlet di WAI-Architecture Think Tank intitolato Pure Hardcore Icons: A Manifesto on Pure Form on Architecture (Artifice Books, London 2013), presentato nelle scorse settimane in un evento speciale alla Beijing Design Week (la mostra correlata è stata aperta al pubblico fino al 7 ottobre 2013).

Questa mia teoria, tutta da verificare, giunge a delle conclusioni un poco diverse rispetto all’analisi di Valle. A ben guardare, è tutto un poco più complicato, e con risvolti inaspettati. Riporto liberamente sotto alcuni estratti dal mio testo per WAI, arricchiti da alcuni pensieri scambiati con Davide Tommaso Ferrando.
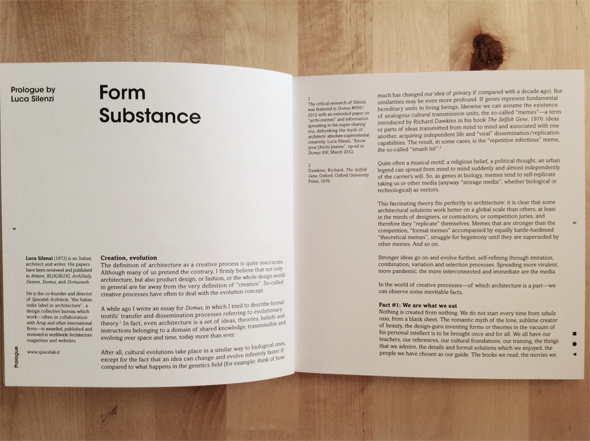
Partiamo dall’inizio, però. Anzitutto assumiamo alla base del nostro ragionamento tre postulati, tre fatti fondamentali.
Fatto #1: Siamo quello che mangiamo. Nulla si crea dal nulla. Qualsiasi risultato del nostro pensiero non nasce per caso, o come per incanto. Non si parte mai dalla tabula rasa, dal foglio bianco. Il mito romantico del solitario, sublime creatore di bellezza, del guru che inventa forme o teorie nel sottovuoto spinto del suo personale intelletto è da far crollare una volta per tutte.
Fatto #2: Progettiamo ciò che riusciamo a rappresentare. L’architettura è una disciplina che si basa su una cosa fondamentale, e cioè sulla capacità dell’uomo di prefigurare realtà alternative. Progettare significa – etimologicamente – portare lo sguardo oltre la condizione presente, “pro-icere”, “gettare in avanti”. Qualcuno direbbe: una lucida preveggenza. Ma, se ci fidiamo del Fatto#1, il futuro che progettiamo viene immaginato in base a concetti, temi e relazioni già presenti nella nostra testa, opportunamente selezionati, combinati e remixati tra loro, più o meno bene e con esiti più o meno convincenti in base alle nostre capacità e alla nostra cultura. Gli strumenti, i materiali, le risorse a nostra disposizione, insieme con la nostra capacità di utilizzarli in modo produttivo, condizionano il risultato dei nostri sforzi progettuali.
È indubbio che riusciamo ad immaginare e a progettare entità che siamo capaci di gestire. Questa capacità, che si è sempre evoluta nel corso dei secoli, ha subìto una considerevole accelerazione negli ultimi decenni: il vantaggio di avere a nostra disposizione innumerevoli add-ons tecnologici – prolungamenti delle nostre capacità di memoria, di rappresentazione, di gestione delle informazioni – ha comportato senza dubbio una precisione ed un controllo delle fasi di ideazione, progetto e realizzazione impensabili fino a poco tempo fa. Permettendoci di progettare oggetti in passato impossibili anche solo da concepire (a questo proposito Davide mi ha ricordato un bel testo di Richard Sennett sui limiti del disegno al computer).
Fatto #3: Costruiamo ciò che sappiamo progettare. L’architettura, almeno quella costruita, a differenza delle altre arti affronta questioni molto complesse. Oltre ad avere spesso una o più funzioni da servire, e dover proteggere – si spera per lungo tempo – i suoi occupanti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici esterni, ha un altro compito ineluttabile e non proprio banale: deve reggersi in piedi. Deve saper affrontare con successo la gravità e le forze dinamiche (venti, sismi, incidenti) cui è sottoposta mantenendo sempre la sicurezza dei suoi occupanti. Non è un dettaglio da poco. Per stare in piedi l’architettura ha a che fare con una inesorabile condizione: la sua dimensione. E si sa, le dimensioni contano.
Contano anche, e non poco, dal punto di vista compositivo. Se riusciamo a far stare in piedi un modellino in scala realizzato in una particolare forma, non è possibile applicare gli stessi rapporti dimensionali ad una scala più grande, semplicemente moltiplicando le tre dimensioni per il fattore di scala: è il cosiddetto principio di similitudine, secondo cui cose di dimensioni diverse avranno bisogno di diverse maniere di sostenersi (mentre il volume – ed il peso – aumenta al cubo del fattore di scala, le sezioni resistenti aumentano solo al quadrato: è il motivo per cui gli insetti giganti della science fiction non potrebbero esistere nella realtà). Man mano che saliamo di dimensione, a parità di concept la bravura del team di progettazione sarà nel non far apparire un edificio troppo goffo.
Piccola parentesi a scanso di equivoci: Davide ha intravisto nel mio ragionamento un concetto di composizione spaziale assoluta, sintetizzata in provetta. Non intendevo assolutamente questo: con soluzione architettonica mi riferisco, dal punto di vista del progettista, a una soluzione architettonica già vagliata (ovvero, come spesso accade, ad una delle varie possibilità – ritenute preliminarmente interessanti – che un progetto ha per concretizzarsi per quel dato tema e in quel dato contesto), che si trova ad affrontare la prova dei fatti, ad essere tecnicamente, funzionalmente e staticamente calzata sul tema specifico del brief. È quello che noi chiamiamo in gergo “fine tuning”, cioè il passaggio dai primi bozzetti alle verifiche più approfondite. È la fase che vede più vittime tra le ipotesi in gioco, in cui darwinianamente l’idea più convincente, o più adatta/adattabile, sopravvive: è anche la fase più sottovalutata dai critici, che troppo spesso si fermano al risultato finale senza approfondire il lavoro di selezione e sintesi che si nasconde in background…
Quindi: sopravvive solo una delle idee iniziali che vengono in mente per un progetto. E molto spesso questa stessa idea – che appariva convincente sotto il profilo funzionale, formale e di rapporto col tema del progetto – è costretta a scendere a compromessi – oltre che con la committenza, con il budget, con la burocrazia, col contesto ecc…. – con qualcosa di ancor più ineluttabile e universale, e cioè le leggi della fisica. Quindi esisterà sempre uno scarto – il più delle volte inevitabile – tra l’idea e la sua concretizzazione in cantiere. Ma il progresso tecnologico non solo ha aumentato le capacità di controllo formale dell’architettura: ci ha fornito anche inediti strumenti per verificare strutturalmente forme complesse, permettendo una maggiore approssimazione dell’idea iniziale anche in condizioni estreme e l’effettiva costruzione a costi ragionevoli.
Da questi tre fatti ineluttabili – in epistemologia potremmo denominarli “concetti primitivi” – possiamo derivare alcune teorie che ci permettono di leggere in modo più rigoroso cosa sta accadendo in architettura e nelle sue soluzioni formali nell’era della super-condivisione.
Teoria #1: In architettura la forma è sostanza. L’architettura riesce ad esprimersi in molti modi. Materiali, massa, trasparenza, leggerezza, texture. Attraverso una sensazione di solidità, o di effimera precarietà. Di calore intimo ed accogliente, o di freddezza austera. Perfino nel ricercato rapporto con i suoni, i rumori, la musica o la nostra stessa voce, nella maniera in cui vengono attutiti o amplificati, o semplicemente ignorati.
L’architettura, la buona architettura, comunica sempre qualcosa.
Ma nulla di tutto questo può essere trasmesso – al visitatore, all’ospite, all’utente: ovviamente siamo noi uomini il destinatario di quella comunicazione – se non attraverso il vettore più importante, il medium principe: la sua forma, e cioè il rapporto dell’architettura con il suo spazio interno ed esterno. Lo spazio – non solo quello interno, che Zevi mi perdoni, e non solo geometrico: ma anche lo spazio relazionale, sociale – viene letteralmente informato dall’architettura, che condiziona il nostro modo di percorrerlo, di attraversarlo, di utilizzarlo, di esperirlo. Di viverlo.
Che sia chiaro: la forma è il mezzo attraverso cui l’uomo ha da sempre organizzato la materia. Si potrebbe dire che la forma è un po’ l’essenza del pensiero umano, capace di razionalizzare la realtà empirica, rimodellandola e discretizzandola secondo le proprie categorie e a proprio vantaggio.
È vero che l’architettura è tridimensionale per antonomasia. Ma non si ferma alle sue dimensioni, al suo ingombro: in architettura l’uomo è riuscito a plasmare, oltre che la materia, anche lo stesso spazio che lo circonda. Dato che lo spazio è l’essenza dell’architettura, ciò che la distingue dalle altre arti o dal design, ne potremmo dedurre che la forma – intesa in termini spaziali e relazionali – è il principale medium architettonico, il più potente. Anzi, inutile girarci intorno, la forma è l’architettura stessa.
Teoria #2: Le forme architettoniche appartengono ad un dominio condiviso di conoscenze. Ne parlai su Domus qualche tempo fa [2]: le forme architettoniche, in base al Postulato #1 sopra introdotto, si “cibano” di forme e concetti preesistenti e li trasformano con più o meno successo in soluzioni formali/spaziali. Tali soluzioni andranno a loro volta a far parte del dominio di conoscenze da cui hanno preso vita, e da cui ulteriori idee trarranno ispirazione e si alimenteranno.
Nell’era della super-condivisione, anche questo dominio di conoscenze è alla portata di chiunque in ogni parte del globo. Per cui è molto probabile che una data soluzione formale possa essere presa a riferimento e trasferita in luoghi totalmente differenti rispetto al contesto storico/geografico/culturale per il quale fu ideata: ho spesso citato gli ordini classici ed il frontone triangolare, che han resistito ben oltre il loro utilizzo nei templi classici (non era forse, quella, una delle tante espressioni dello show-system architettonico, anch’essa “pura messinscena” totalmente svincolata dalla funzione?).
In altre occasioni ho fatto l’esempio dei virus che a differenza dei secoli passati oggi sono capaci di muoversi da un continente all’altro anche grazie al trasporto aereo: vettori più efficienti favoriscono esponenzialmente le possibilità di trasferimento dell’ “infezione”, con le conseguenze estreme di una vera e propria “pandemia”. Allo stesso modo mezzi sempre più potenti per la condivisione delle informazioni permettono una diffusione “pandemica” di memi, o tropi, o replicatori (anche architettonici) di successo.
Ma l’architettura ha un limite: ha bisogno di noi per riprodursi. L’evoluzione della specie formale architettonica si serve dell’uomo/progettista, della sua mente, dei suoi mezzi compositivi, senza cui sarebbe materia morta. Le idee si servono di noi per riprodursi e diffondersi. Le idee migliori dal punto di vista evolutivo – o meglio, come mi suggerisce Davide di sottolineare, più forti, e non è detto che ci piacciano – vanno avanti e proliferano. Altre, magari ottime in sé, non hanno successo nel loro ambiente e sono destinate all’estinzione. Alcune sembrano aver accompagnato da sempre il percorso dell’uomo, e tendono a scomparire e riaffiorare nel corso dei millenni, come un fiume carsico.
Teoria #3: Le forme pure ed iconiche sono tra i memi/tropi con più alta capacità di replicazione e diffusione a scala planetaria. In questo processo continuo di inconsapevole crowdsourcing con cui facciamo nascere o evolvere idee, teorie, convinzioni, istruzioni – di cui è costituito anche il linguaggio architettonico e i suoi approcci spaziali – alcuni temi (non solo formali) hanno più successo di altri, e tendono a perpetuarsi o a riaffiorare nel corso della storia in base a quanto riescono ad essere convincenti nella mente dell’uomo (sia esso progettista, o committente, o membro di giuria nei concorsi di architettura).
Il tema della forma pura è un concetto a noi caro fin dall’alba della ragione umana. Un concetto potentissimo, protoculturale, che tocca corde profonde del nostro intelletto e del nostro inconscio, avendo a che fare col nostro desiderio innato di razionalizzare il mondo che ci circonda.
Ora qual’è il problema vero: le forme pure sono state sempre difficilissime da tradurre in architettura, che per ragioni tecniche in passato aveva bisogno di soluzioni tecnologiche piuttosto rigide ed ingombranti per resistere alle intemperie e al tempo: le “forme pure” dei secoli passati erano spesso offuscate da strati di sacrificio, coperture, gronde, infissi da installare non a filo, cornici per mascherare eventuali tolleranze di costruzione. Molto spesso le forme pure erano relegate a schemi generatori di riferimento, quasi mai espresse concretamente nella realizzazione pratica (con qualche illustre eccezione, come le geometrie piramidali, resistenti già per forma ai carichi e alle intemperie e staticamente semplici da realizzare senza troppi problemi tanto da sfidare i millenni; oppure la forma sferica, più spesso concretizzata “in negativo” come nel Pantheon di Roma).
Ma il progresso tecnologico, l’evoluzione dei materiali e dei sistemi di facciata sempre più sofisticati, il livello di controllo minuzioso già in fase di elaborazione dell’idea architettonica permesso dai moderni programmi di progettazione BIM hanno comportato in tempi recenti una diffusione sempre più accelerata delle pure, hardcore forms [3], oggi più che mai concretamente realizzabili anche in edifici di dimensioni ragguardevoli, e con esiti costruttivi prossimi alla perfezione.
Cosa faccio notare in calce al testo di Valle: che – molto più in tempi recenti che non all’epoca dei pionieri del Moderno – paradossalmente le forme pure assolute hanno trovato una ragion d’essere in soluzioni di dettaglio sempre più convincenti. Fino a qualche anno fa non era semplicemente possibile realizzare le “forme sommarie” di cui Valle parla. Non c’erano i materiali e le tecnologie giuste per farlo. Oggi tali forme sono realizzabili ovunque nel mondo, sia da chi rappresenta l’avanguardia di questo mestiere che da tutto il codazzo di cosplayer che segue.
Per la loro essenza sovra-geografica e per l’innato fascino che provocano in noi uomini, le forme pure hanno trovato di nuovo il loro tempo. Oggi più che mai, oltre che per il fatto fondamentale di essere finalmente cantierabili, anche per la loro immediatezza e per la loro natura render-genica.
Indubbiamente, nell’era dei “born digital media” e della loro essenza post-editoriale e post-curatoriale – “con l’atto critico ridotto a mero conteggio di likes, retweet e repins” [4] – l’immediatezza può rappresentare un vantaggio, un’arma vincente in una competizione globale sempre più sfrenata. E qua sono d’accordo con Valle: non sempre i risultati sono all’altezza delle aspettative dei gourmet. Ma questo avviene anche nei migliori ristoranti…
C’è comunque da sottolineare che, all’interno di concorsi internazionali di architettura sempre più affollati, una forma pura, immediata e spettacolare alla scala urbana avrà più probabilità di colpire al primo sguardo una commissione di giuria rispetto ad un’altra concorrente compositivamente più tranquilla, e magari meglio supportata sotto il profilo teorico e di aderenza al brief. Accade sempre più spesso. E il motivo è sempre quello: le forme pure, oggi tecnologicamente realizzabili, si rivelano perfettamente adatte ai media con cui oggi vengono divulgate al mondo. Infatti, chi vince nell’evoluzione non è il più forte in senso assoluto, ma colui che è capace di adattarsi più facilmente alle condizioni dell’ambiente.
Certo, come dicevo sopra so bene che la forma non è tutto. Il problema però è che in molti sono ancora “amanti del criptico e del fantomatico mistero dell’architettura” [5]. Molto spesso questo atteggiamento snobistico nei confronti dell’opera architettonica si traduce in linguaggi critici e compositivi inutilmente affettati e complicati, tanto da rendere un’opera o un approccio teorico masochisticamente incomprensibile. In realtà molto di questo inutile lavoro resta spesso nei pensieri dei progettisti e dei critici e nella stampa specializzata, mentre la vera eredità dell’opera architettonica – eredità fortemente democratica, percepibile ed accessibile da tutti – è proprio, ahimé (o per fortuna), nel suo aspetto esteriore, nel suo spazio e nel suo rapporto di lettura o rottura rispetto al contesto. Cioè nella sua forma.
Delle stroncature o delle recensioni critiche positive, dell’immensa cultura o dell’inadeguatezza del progettista e dei suoi retropensieri molto spesso non resta traccia.
Quindi: a dispetto di tante sovrastrutture teoriche in cui spesso noi stessi architetti amiamo perderci, spesso vale la pena di ricordarci che l’architettura viene progettata e costruita per rispondere ad umanissimi – spesso banalissimi – requisiti, e nella forma che ne ha stabilito il successo rispetto ad altre alternative possibili, lasciando dietro di sé innumerevoli vittime.
E oggi più che mai, in questo processo continuo di ridefinizione, con stakeholder, estimatori e pubblico sempre meno “iniziati” al criptico e fantomatico mistero dell’architettura sopra citato, le forme pure rappresentano approcci compositivi vincenti alla scala globale. Approcci compositivi oggi tecnicamente concretizzabili, ma che trovano origine all’alba della civiltà, e nelle fondamenta della stessa ragione umana.
Luca Silenzi
Note:
[1] AARON BETSKY, Building sex: men, women, architecture, and the construction of sexuality, William Morrow, 1995.
[2] E, più recentemente, in LUCA SILENZI, Reverse engineering of architectural tropes – Working hypothesis for a phylogenetic map of architectural language in the super-sharing era, in “STUDIO” n.5, pp. 44-51.
[3] WAI Think Tank, The shapes of Hardcore Architecture, in “Conditions Magazine n.2: Copy, Interpretation”, ottobre 2009.
[4] SAM JACOB, How can culture exist in a stream of Photoshopped incontinence?, in “Dezeen”, 24 gennaio 2013.
[5] BJARKE INGELS talking about complexity in Being BIG, in “Abitare” n.528/2012, p. 117.
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.








Lascia un commento