Punto e a capo per la critica in Italia (n.2)
massa critica | valerio paolo mosco
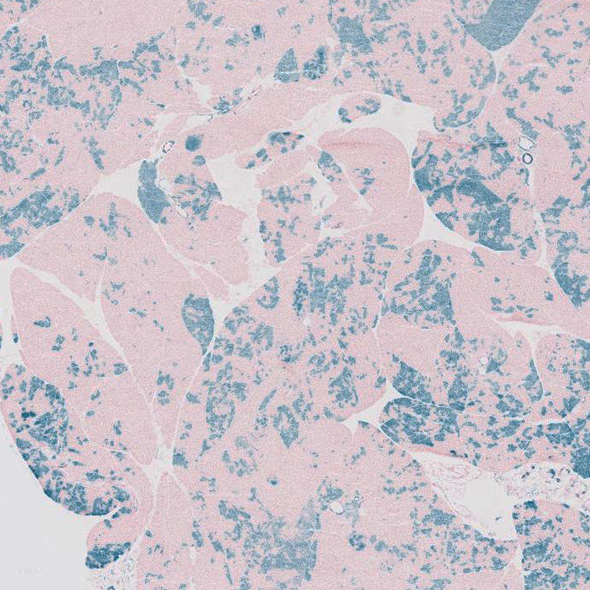
Ho letto con interesse lo scritto di Luca Molinari per la rivista olandese Volume (pubblicato anche sul sito ilPost) sulla debolezza della critica in Italia il cui titolo, “la critica per l’architettura in Italia; punto e a capo”, parafrasa una nota conferenza di Persico. Allo scritto di Molinari rispondo con ulteriori argomentazioni. Partirei dalla più banale. Si potrebbe obiettare in prima battuta che la presunta debolezza derivi e rispecchi una ormai comprovata debolezza della stessa produzione architettonica. Vero, ma solo in parte, anzi in parte relativa.
Consideriamo, con necessaria approssimazione, la produzione degli ultimi decenni. Ebbene nel periodo del presunto “gran declino” la nostra architettura ha dato prova, nonostante le oggettive difficoltà di mercato, di grande vitalità presentando un’offerta la cui varietà è difficilmente riscontrabile in altri paesi. Vale la pena fare un elenco che gradirei fare geografico. Inizierei dal sud, dai tardi anni ’80, con la scuola di Palermo, mediterranea e topografica in contatto diretto con Alvaro Siza. Poi, risalendo, Napoli con quell’insistere sul disegno, sul linguaggio immaginifico del residuale, del contaminato, sul vitalismo popolare che, come nel caso di Beniamino Servino o Cherubino Gambardella, riesce a prospettare una monumentalità altra, in bilico tra l’aulico e l’abbandonico. Risaliti in una Roma viene in mente negli anni ’90 una tendenza analitica al progetto che forse inconsciamente è riuscita a dar forma al pensiero critico di Filiberto Menna, mettendo a reagire lo stesso con il modernismo internazionale (Labics, Ian+, Nemesi). A ritroso, sempre a Roma, la stagione della “Roma interrotta”, del post-moderno liberatorio e un po’ kitsch, alle volte irritante per la sua capacità di devitalizzare qualunque cosa, ma indubbiamente ricco. Ancora a Roma la breve stagione anch’essa tardi anni ’90, dell’architettura spontanea e situazionista degli Stalker o quella partecipativa di gruppi come Ma0. Spostandoci a est, siamo ancora negli anni ’90, la scuola di Pescara che interpretava la “città adriatica” come modello. Desideri in un suo fortunato libro la chiamava “città di latta”, in definitiva una Las Vegas nazionale, ovvero il luogo dove la realtà non progettata aveva oltrepassato la fantasia e che come tale aveva moto da insegnare all’architettura alta. Una scuola, quella di Pescara, che trovava a Roma il suo rimando (penso ad Antonino Terranova) e che rileggeva forme edilizie secondarie, come le palazzine e che capitalizzava il tutto in uno stile fatto di spezzate e frammenti giustapposti che nelle migliori espressioni (Aymonino, Andriani, ABDR, Vaccarini) ha avuto la capacità di prospettare una suggestiva strategia di nobilitazione dei linguaggi spontanei. A nord, a Milano, abbiamo avuto una revisione critica della propria tradizione che ha cercato di interporsi tra la Tendenza ed il “realismo” di Bpr, Albini, Gardella, Asnago e Vender, Caccia Dominioni. Nei casi di maggior pregio (Cino Zucchi, PiùArch, Park Associati e a Udine Studio Geza) questa interpretazione ha privilegiato una concezione del fare architettura come arte del decoro, ottenibile attraverso una architettura colta e sobria, in definitiva una forma di composta e silente resistenza nei confronti di quel “Paese senza architettura” di cui scrive Pippo Ciorra. Ancora a Milano abbiamo assistito ad una tendenza di tipo opposto, che ha visto nel design, nell’oggetto di architettura considerato come oggetto d’uso, uno strumento per andar oltre quegli impasse, considerati insormontabili dell’architettura della città. Paradigmatico a riguardo è il lavoro di Italo Rota. Per ultimo, nel panorama milanese, viene in mente nella prima metà degli anni ’90, la ripresa degli studi geografici ed antropologici applicati su un territorio che era sfuggito di mano, quello dell’hinterland milanese. Il lavoro di Boeri, Lanzani e Marini, (che deve non poco alla lezione di Bernardo Secchi) rimane una delle più interessanti operazioni di studio urbanistico compiuto non solo nel nostro Paese; un lavoro che come quello della scuola di Pescara, anche se propagandava per ragioni ideologiche un disinteresse programmatico nei confronti del linguaggio, di fatto lo evocava con un modernismo elementare, se non stilizzato, alternativo ma non conflittuale rispetto alla città-territorio semi-spontanea a cui intendeva relazionarsi. A Torino abbiamo assistito da un lato ad una breve stagione della rivalutazione dell’architettura auto-costruita e spontanea e contemporaneamente al puntuale emergere di architetti come Stefano Pujatti, provocatori ed eretici, tendenzialmente contrari ad ogni senso dell’ordine precostituito. L’esatto contrario a quanto alcuni delle nuove generazioni (Baukuh, Sp10, 2a+p, Salottobuono) stanno cercando, ovvero un’architettura assoluta ed iconica, di sfondo, in alcuni casi quasi afasica. Una tendenza che confrontandosi con il lavoro critico di Pier Vittorio Aureli, è riuscita a produrre il più interessante progetto editoriale degli ultimi anni: la rivista San Rocco. A questa lista si aggiunge inoltre l’altalenante modernismo muscolare di Fuksas, quello più intellettuale e sulfureo di 5+1 e quello più “alla Renzo Piano” di Mario Cucinella. Per finire, tornando agli inizi, vanno ricordate le architetture e l’impegno critico di maestri come Gregotti, Purini, Secchi, Nicolin, Monestiroli, Mendini che ancora oggi testimoniano un impegno che anche per coloro che tendono a distanziarsene, rappresenta un innegabile elemento di riferimento. Per ultimo le ricerche dei non assimilabili a nessuna corrente, come quella di Renato Rizzi.
La noiosità di questa lista (che chiaramente potrebbe continuare) è voluta in quanto necessaria per puntualizzare il fatto che a questa ricca offerta non è corrisposto un altrettanto ricco dibattito, ovvero non è corrisposta una altrettanto ricca produzione critica. Il materiale quindi per fare critica non solo c’è stato, ma persino è stato sovrabbondante. Invece i critici hanno risposto a ciò astenendosi dai giudizi di valore selettivi, per cui dal praticare il loro lavoro. Lasciate quindi a loro stesse, private della polarità esterna del giudizio critico, le tante ipotesi che l’architettura italiana ha proposto e continua a proporre, si sono avvilite e su di esse è calato l’ingiusto velo unificante della dimenticabilità. Va detto che per coloro i quali prima si occupavano di giudizi di valore, i critici, il cambiamento di status è apparso conveniente. Nel disimpegno era infatti finalmente possibile vagare liberi senza la peggiore delle responsabilità: quella delle proprie idee. Il momento era inoltre propizio. Il post-moderno imponeva infatti un atteggiamento culturale distaccato e divagante per cui le opere di architettura altro non erano che stimoli per discorsi altri, tangenziali alle questioni legate specificatamente al valore dell’opera, ovvero al suo linguaggio. Così nella rabberciata utopia post-moderna secondo la quale non ci sarebbero dovute essere verità o presunte verità, ma solo interpretazioni, la critica inevitabilmente è andata riducendosi ad una comoda chiosa del già accaduto, possibilmente di fatti accaduti da altre parti, possibilmente confezionati in modo tale da apparire nuovi. E’ diventata il contrario di quanto aveva ipotizzando Baudelaire, che scriveva: “…credo che la migliore critica debba essere parziale, appassionata e politica, vale a dire condotta con esclusività, ma tale da aprire il più ampio degli orizzonti”. Baudelaire di fatto enuncia una verità: la critica va condotta con esclusività, senza esclusività la stessa evapora. Era dunque difficile, negli ultimi decenni in cui il paradigma imperante è stato l’inclusività, che l’esclusività avesse vita facile. Ciò non è avvenuto solo in italia. I danni del chiacchiericcio inclusivo e divagante post-moderno sono stati anche maggiori negli Stati Uniti o in Francia. Baudelaire è chiaro anche su un altro punto: bisogna essere esclusivi in modo tale da aprire il più ampio degli orizzonti possibili. E’ stato proprio questo il duplice registro che connota il lavoro dei grandi critici, a cui perdoniamo gli abbagli, le cadute di tono, le idiosincrasie e persino le patologie perché attraverso il loro selezionare, persino feroce, attivano nella nostra mente idee ed intuizioni capaci anche di andare oltre il loro stesso pensiero, alle volte persino contro. Dunque, nel regime della grande inclusività i critici si sono adattati, cambiando di fatto mestiere, diventando cerimonieri dei regimi culturali correnti. Girava allora nell’aria una parola di moda ed allora si organizzava immediatamente un convegno o un happening o persino una “festa” in cui includere tutti. Il rito era semplice: ognuno dei tutti avrebbe dovuto interpretare il termine evitando il più possibile quel giudizio di valore che avrebbe inevitabilmente comportato una presa di distanza dall’interpretazione di qualcun altro. Un rito che, considerata l’infinita lista degli “eventi”, evidentemente soddisfaceva tutti. Il prezzo del rito era altrettanto evidente: il declino del dibattito e con esso il declino della visibilità dell’architettura italiana.
Ripeto: ciò non è avvenuto solo in un Italia, ma da noi gli effetti negativi di questo atteggiamento disimpegnato sono stati anche peggiori rispetto altre parti. Esiste poi una patologia specificatamente italiana che a mio avviso è riferibile alla difficile eredità lasciata da un grande critico: Manfredo Tafuri. Sin dalla fine degli anni ’70 Tafuri porta alle estreme conseguenze la concezione marxista iconoclasta per cui il linguaggio altro non è che l’ennesimo travestimento, seducente e sviante, di un capitalismo sempre alla ricerca di forme con cui riciclarsi. La ricchezza linguistica dell’architettura contemporanea, da Tafuri definita iper-moderna, diventa così nella rapsodica prosa dell’autore un gioco ipertrofico a somma zero destinato, come il capitalismo, all’entropia. L’argomentazione ideologica di Tafuri inevitabilmente acquista il valore di un appello secondo il quale sarebbe stata necessaria da parte dei critici operare una continua opera di smascheramento alla ricerca di una vera sostanza critica trovabile solo al di là del gioco di specchi del linguaggio. In definitiva la critica sarebbe dovuta diventare, secondo un modello tipico degli anni ’70, metacritica. Come sappiamo, dopo i crudeli, forse cinici, ma toccanti saggi dello smascheramento Tafuri abbandona l’iper-moderno per rifugiarsi nel Rinascimento veneziano, regalandoci un magnifico libro che però tristemente rimarca una distanza con la contemporaneità ormai incolmabile. Ultimo capitolo del Tafuri critico della contemporaneità, è una dimenticabile Storia dell’architettura italiana; un lavoro distaccato e scettico, in cui la ricerca di strutture altre rispetto alle banali vaporosità del linguaggio scivola in una compilazione poco attraente, di cui rimangono memorabili soltanto gli abbagli, come le stroncature di due indiscutibili capolavori come il grattacielo Pirelli di Ponti, Danuso e Nervi e la Rinascente di Franco Albini e Franca Helg . Un’eredità difficile quindi quella di Tafuri e se da un lato ha ragione Marco Biraghi [1] ad affermare che senza la scaltrezza smascherante di Tafuri gran parte del pensiero di Rem Koolhaas avrebbe perso la sua verve, dall’altra la delegittimazione del linguaggio, ha contribuito in maniera determinante alla deresponsabilizzazione critica, fornendo alla stessa un precedente illustre a cui appellarsi. Il risultato dopo la morte di Tafuri è stato così una pressoché illimitata sequenza di argomentazioni interpretative che parlando di tutto si sono ridotte a niente. L’esempio più eclatante è stato l’inesauribile discorso sui nuovi media, sul potere della rete e sulla tecnologia della comunicazione, o quello sulla sociologia, aspetti di cui sono stati colti, come spesso accade agli architetti che si occupano di altre faccende, solo gli aspetti più superficiali.
C’è da dire che l’operazione di delegittimazione di Tafuri della critica del linguaggio ha avuto la strada spianata dal declino della stessa. Un declino evidente proprio nel suo massimo esponente, Bruno Zevi.
Come si sa la costruzione critica di Zevi è un peculiare prodotto di sintesi tra purovisibilismo, idealismo crociano (a cui si aggiunge De Sanctis) e verve militante alla Persico, ingredienti tenuti insieme dalla fede che l’analisi critica del linguaggio avrebbe identificato le tendenze e con esse i paradigmi generali che sottendono le stesse. Questo impianto critico, in definitiva deduttivo, che in passato aveva permesso allo stesso Zevi operazioni di livello internazionale, come il rilancio dell’ultimo Wright o l’apertura verso l’architettura anonima e vernacolare è stato essenziale nello sviluppo dell’architettura italiana. Esso infatti ha contribuito in maniera determinate a fare in modo che sin dagli anni ’50 gli eredi del senso dell’ordine del razionalismo italiano trovassero nel principio organico propagandato da Zevi il necessario reagente per rivitalizzare un linguaggio che aveva perso l’originaria carica propulsiva. Nonostante questa eredità di rilievo (forse il caso di maggiore influenza critica sull’operato di più di una generazione di architetti) Zevi in quello che si può considerare il suo testamento intellettuale, il Manifesto di Modena [2], svilisce la sua argomentata costruzione schiacciandola su tesi che ormai hanno perso la plasticità argomentativa del passato. Nel Manifesto egli afferma infatti che finalmente la “battaglia dell’architettura moderna” era vinta in quanto l’allora imperante decostruttivismo dimostrava che modernismo e senso organico avevano trovato finalmente una sintesi operativa. Sarebbe bastato quindi continuare a storcere ancora di più gli edifici, deflagarli arbitrariamente, congestionarli oltre la ragionevolezza, renderli organismi compulsivi come tribolanti figure manieriste, per arrivare al porto sicuro di una modernità paga dei suoi stessi tormenti. La pochezza delle argomentazioni di Zevi nel breve testo del Manifesto è allarmante; rileggendola si ha già il sapore di quel chiacchiericcio per slogan che da allora in poi avrebbe nutrito il battibecco ad oltranza del web.
La difficile eredità dei due maggiori critici italiani, Tafuri e Zevi, gli unici tra l’altro tradotti con continuità all’estero, ha determinato un impasse per la critica nazionale che si perpetua tutt’oggi. Schiacciata quindi da un lato dalla demonizzazione ideologica del linguaggio e dall’altro dalla esaltazione acritica dello stesso, la critica ragionata, ovvero la volontà di meditata attenzione nei confronti del singolo pezzo alla ricerca delle leve capaci di chiarirne gli aspetti espressivi, non solo ha perso dignità, ma è stata apertamente combattuta e alla fine delegittimata. Nell’impasse si è allora creato un vuoto riempito da un’Accademia sempre più seduta su se stessa, tanto da perdere negli ultimi anni un primato mai messo fin’ora in crisi, ovvero l’essere stato il luogo fisico in cui si sono concentrate le migliori testimonianze del dibattito architettonico.
Se allora iniziassimo a riflettere (finalmente) sulle tante occasioni di architettura passate, sul perché la critica negli ultimi venti anni non è riuscita a valorizzare le stesse attraverso la selezione dell’offerta, se (finalmente) l’eredità dei maestri venisse considerata non come celebrazione ma come opera in atto al di là del volere degli stessi autori, se (finalmente) cessasse il lamentismo del “paese senza architettura”, se si prendesse (finalmente) le distanze da quella mediocrità paradossalmente aggressiva che è diventata il tessuto connettivo di un dibattito ormai imbrigliato dai suoi stessi comportamenti, e se (finalmente) si smettesse di dare credito agli officianti del sottobosco fatto di inutili eventi e convegni e persino fatto di sottobosco (come il drammatico ultimo padiglione italiano alla Biennale), allora potremmo far nostra l’esortazione di Persico, ribadita da Molinari, di un non più procrastinabile punto e a capo per la riflessione critica in Italia.
Cercare le ragioni di quel lassismo critico che ha pervaso gli ultimi anni è un’operazione necessaria, ma non sufficiente. Riamane infatti evasa la domanda su quale debba essere il ruolo di un critico oggi. Per rispondere bastano a mio avviso le argomentazioni di Giorgio Agamben e Alfonso Berardinelli. Agamben scrive: “può dirsi contemporaneo soltanto chi non si lascia accecare dalle luci del secolo e riesce a scorgere in esse la parte dell’ombra, la loro intima oscurità” [3]. Essere contemporanei corrisponde quindi alla maturazione di un atteggiamento critico nei confronti della stessa modernità. Questo atteggiamento prende dunque le distanze sia da coloro i quali assecondando gli eventi e così ne rimangono abbagliati, come spesso è accaduto al moderno e paradossalmente anche in modo più accentuato, nel post-moderno, ma anche nei confronti di coloro i quali cercano di smascherare senza pietà la fragile ma non innocente contemporaneità, optando così per una delegittimazione del linguaggio che inevitabilmente scivola nel nichilismo. Neppure scegliere quel distacco proposto da Gregotti, pedagogico e dirigista, che inevitabilmente scivola nel propagandare una mediocrità avversa ad ogni intuizione artistica del fare architettura. Alfonso Berardinelli radicalizza ulteriormente la posizione di Agamben [4]. Egli parte da una osservazione che è particolarmente valida per l’architettura. “così nel secolo della politica, delle scienze sociali e della tecnocrazia, gli stessi intellettuali hanno cominciato a vedere se stessi come un’entità collettiva. Si sono valutati e studiati in quanto ruolo e funzione sociale, o strumento utile in vista di scopi politici”. Ed aggiunge: “ma non andrebbe dimenticato che anche come prodotto sociale gli intellettuali sono e funzionano soprattutto come individui. La loro attività e il loro modo di essere consistono in una valorizzazione pubblica dell’individuo”. Un critico quindi per Berardinelli è innanzitutto il contrario delle tante figure che negli ultimi anni hanno svolazzato intorno all’architettura. In definitiva non è un “uomo socievole”, pronto ad ubbidire alle regole non scritte ma ferree dell’ambiente, e non lo è in quanto sa che per eccesso di socievolezza perderebbe quella distanza critica da cui dipende la sua indipendenza di giudizio. Berardinelli giunge ad affermare che un critico deve essere un misantropo. D’altro canto è difficile dargli torto perché misantropi sono stati Montaigne, Saint-Beuve, Baudelaire, Krauss, Benjamin, Barthes e da noi Fortini e Pasolini, ovvero alcuni dei grandi critici. Ancora una volta l’ideologia post-moderna impostata sul disimpegno, sulla eliminazione programmatica del giudizio di valore nella speranza (fallita miseramente) di poter indirizzare gli eventi attraverso manovre collettive ci ha allontanati dall’evidenza che la critica si fa con il distacco, che contemporaneamente deve riguardare sia il pensiero che il comportamento. Si potrebbe obiettare a ciò che la critica deve essere militante per cui non può essere misantropica. Affermando ciò ci si dimentica che il distacco non è pregiudiziale alla militanza, anzi il lavoro del critico si pone proprio in bilico tra i due termini, li tesse insieme neutralizzandoli in maniera tale da poter ottenere un tessuto argomentativo da cui traspare chiaro ma in filigrana per non perdere le sfumature, il proprio pensiero. Questi precetti sono ancor più chiari se li si considera come l’esatto contrario del linguaggio del web, in cui la distanza critica è abolita nel botta e risposta compulsivo, fatto di slogan e di un profluvio di frasi principali incapaci di tenere qualunque subordinata per cui qualunque argomentazione.
E se qualcuno di più radicale, che si considera più smagato (negli ultimi anni ne abbiamo visti molti) pensa che la stessa critica sia ormai un orpello di altri tempi, la risposta viene ancora da Berardinelli: “la critica è il sistema endocrino della letteratura. Non si vede ma se funziona male, tutti gli altri apparati e sistemi si ammalano. Se il sistema endocrino è pigro o gli ormoni critici non entrano in circolo, il corpo letterario diventa obeso, o inutilmente agitato, o sterile”. E’ necessario dunque riattivare il prima possibile questo sistema endocrino: i guai di averlo congelato sono ormai sotto gli occhi di tutti e su ciò almeno si può concordare per fissare il punto voluto da Persico. Per il daccapo poi si può, anzi è necessario, discordare.
Valerio Paolo Mosco
(luglio 2013)
Note:
[1] Marco Biraghi, Progetto di crisi; Manfredo Tafuri e l’architettura contemporanea, Edizioni Marinotti, Milano 2008.
[2] Bruno Zevi, Il manifesto di Modena: paesaggistica e grado zero della scrittura architettonica, Canal e Stamperie edizioni, 1998.
[3] Giorgio Agamben, Nudità, Nottetempo, 2010.
[4] Alfonso Berardinelli, Che razza di intellettuale sei?, Nottetempo, 2011.
Related Posts
Una risposta a “Punto e a capo per la critica in Italia (n.2)”
Lascia un commento Annulla risposta
Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.


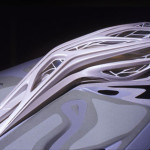





Ho letto con vero piacere questo scritto di Valerio Paolo Mosco. Un piacere datomi dall’essere d’accordo su due punti: il primo è la mia assoluta aderenza sull’inadempienza della critica a voler leggere le trame e le connessioni che si dipanano nell’architettura contemporanea. Quella dell’inclusivismo è la vera piaga della critica contemporanea italiana. Il termine “critica” deriva, come ci ricorda Kant, dalla parola greca κρὶνω, ossia “distinguo”. L’azione del “distinguere” non prevede l’inclusione di elementi spuri, tutt’altro! La critica deve essere rigida ed inflessibile. L’inclusivismo di Molinari del suo articolo (cielo, quando ho letto alcuni nomi ho avuto quasi un mancamento!) tende al giornalismo di settore. La critica è un’altra cosa. Parlare di un argomento descrivendolo non è un’operazione critica. L’operazione critica prevede l’esclusione di elementi, e la lettura su di un piano coerente di significato. Questa operazione tende a fornire alcuni strumenti di lettura della realtà. Ad esempio, se Michel Ragon non si interessa minimamente, o lo fa poco e velocemente, delle correnti razionaliste locali, non è perché non le ritiene importanti o degne, ma perché nel suo piano di significato non trovano posto. Per cui il razionalismo italiano è stato da lui quasi estromesso dal discorso storico.
Il secondo motivo per cui esulto leggendo l’articolo, è il suo spostare il riflettore su un aspetto che mi ha sempre interessato, ossia quello della “comunicazione”. A tal proposito suggerisco a gran voce la lettura del libro di Mario Perniola, “Contro la Comunicazione”; In questo libro viene messo in evidenza come la necessità del “tempo reale” si tramuta velocemente in dipendenza da consumo di informazioni – che poi sfocia in una sindrome chiamata “infornografia”. Questa sindrome mi permetto di diagnosticarla alla critica dell’architettura italiana. Se una delle caratteristiche della critica è la riflessione, questa viene sostituita dal bisogno continuo di esporre la propria opinione, che come viene evidenziato, assume sempre più il tono di un “motto”.
A questo vorrei aggiungere una piccola postilla: non sono persuaso che esista questa grande ricchezza progettuale in Italia. Di sicuro mancano le chiavi critiche, però è tutto il sistema “architettura” ad essere in crisi…